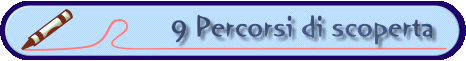
La straordinaria storia delle Alpi e dell'Oceano prealpino
|
|
Dissesto idrogeologico
Frane, valanghe, inondazioni sono le principali manifestazioni del dissesto idrogeologico cui le zone alpine sono particolarmente soggette a causa della forza di gravità che agisce sui versanti, spesso molto ripidi. Un ’altra causa di questi pericolosi fenomeni è l’incuria e l’imprevidenza dell’uomo che ha abbandonato la montagna al suo destino, senza più curarsi della manutenzione che i vecchi montanari effettuavano per esempio pulendo il letto dei rii e curando i boschi senza effettuare opere di disboscamento eccessive.
Le frane
Le valli, le montagne e le pianure sono abitualmente considerate come strutture che non cambiano nel tempo. In realtà la superficie del nostro pianeta si trasforma di continuo, ma in modo troppo lento perché noi possiamo accorgercene solo in alcuni casi, come appunto quello delle frane, gli eventi subiscono una brutta accelerazione e in pochi attimi la natura svolge un lavoro che altrimenti richiederebbe migliaia se non milioni di anni.
Il meccanismo di una frana si può
spiegare in questo modo: il materiale che costituisce un pendio, una scarpata o
una parete rocciosa, è attirato verso il basso dalla gravità, la forza che da
peso a ogni oggetto. Rimane in quella posizione perché delle resistenze interne
lo trattengono.
Questo equilibrio di forze dipende
da fattori come la natura del terreno o della roccia, la forma (o profilo) del
pendio o la quantità di acqua presente.
Tali condizioni possono cambiare,
per cause naturali o artificiali. In questo caso l’equilibrio si può spezzare in
favore della forza di gravità, che vince le resistenza interne e trascina il
materiale verso il basso causando, in altre parole, una frana.
Le frane possono quindi essere
definite come “movimenti di materiale solido che, in virtù della loro condizione
di persistente instabilità, vengono trascinate istantaneamente verso il basso
per effetto della sola forza di gravità”.
I movimenti franosi si verificano in una determinata area per effetto della concomitanza di diversi fattori sfavorevoli alla stabilità di un versante; appare quindi evidente che la determinazione ed il controllo di tali fattori aiuta ad evitare il ripetersi degli eventi negativi che generano danno all’uomo.
I fattori da tenere sotto
controllo sul territorio sono numerosissimi e riguardano diversi aspetti
(naturali, antropici, geologici, ecc.); alcuni di essi risultano caratteristici
di un versante e rimangono invariati nel corso del tempo, altri invece devono
essere soggetti a controlli periodici o ancor meglio in continuo per la loro
rapida variabilità.
Alla prima categoria appartengono:
Fattori geologici ovvero
riguardanti il tipo di roccia che costituisce l’area di interesse, sia in
affioramento sia in profondità.
Fattori idrogeologici quali
la permeabilità delle formazioni rocciose che condiziona il tipo di circolazione
idrica superficiale e sotterranea; quest’ultimo fattore risulta essere in
assoluto uno dei più importanti in quanto la circolazione delle acque
sotterranee è collegata all’entità ed alla distribuzione delle pressioni che
sono spesso causa dei fenomeni franosi.
Fattori morfologici ovvero
le pendenze dei versanti dell’area di interesse che rivestono particolare
importanza, poiché la forza che permette il movimento della frana è quella di
gravità, per cui tanto più è inclinata la superficie topografica, tanto maggiore
è l’instabilità (in quanto determina l’aumento della sollecitazione al taglio
applicata al versante) e la velocità con la quale il movimento franoso si
esplicherà.
Fattori strutturali quali
la presenza o meno di fratture o faglie, superfici di stratificazione,
scistosità (orientazione degli strati di roccia dovuta all’effetto della
pressione esercitata) e quant’altro possa costituire una superficie di debolezza
del deposito.
Alla seconda categoria di fattori (che quelli cioè cambiano velocemente nel tempo) appartengono invece.
Fattori climatici e vegetazione che svolgono un ruolo determinante nell’innesco dei fenomeni franosi, soprattutto nei climi dove si alternano lunghe stagioni secche a periodi di intensa e/o prolungata piovosità. Ciò può comportare sia variazioni di portata della rete drenante superficiale con incrementi delle azioni erosive, sia innalzamenti delle superfici libere delle falde acquifere sotterranee, con effetti particolarmente negativi, soprattutto quando le falde sono prossime alla superficie topografica. Per quanto concerne poi la vegetazione, una estesa copertura boschiva costituisce un naturale ostacolo all’azione degli agenti atmosferici.
Fattori antropici ovvero legati all’azione dell’uomo; queste possono essere attive quali gli scavi, gli appesantimenti dei versanti o i disboscamenti, possono essere passive, quali l’abbandono delle terre, svolgono un ruolo di accelerazione dei processi morfogenetici, provocando reazioni fino alla rapida alterazione degli equilibri naturali.
Con il termine frana si indicano tutti i fenomeni di caduta ed i movimenti di masse rocciose o di terreni causati prevalentemente dalle forze di gravità.
Le valanghe
La valanga è una massa di neve ed
eventualmente rocce, terra e ghiaccio che precipita a valle da un pendio più o
meno ripido; essa può provocare danni all’ambiente ed anche all’uomo,
costituisce quindi un fenomeno che deve essere ben conosciuto dai frequentatori
della montagna poiché sottovalutare la sua potenzialità può costare la vita.
FATTORI CHE CONTRIBUISCONO ALLA FORMAZIONE DELLE VALANGHE
1 - Tipi e intensità delle
precipitazioni
2 - Direzione e velocità del vento
3 - Temperature e scambio termico
sulla superficie della neve
1 - Il clima delle nostre regioni è caratterizzato da precipitazioni nevose relativamente scarse e basse temperature. Qui il manto nevoso presenta spessori modesti ed e spesso instabile a causa di debolezze strutturali interne che provocano rotture degli strati.
Molte di queste rotture si verificano anche in neve fresca.
Accumuli da parte del vento possono innescare processi di disgregazione negli strati di neve vecchia.
A causa del manto poco profondo, il processo di ricristallizzazione indebolisce la neve vecchia in presenza di basse temperature.
2 – La direzione e la velocità del vento contribuiscono all'accumulo di neve ed anche al distacco della valanga. La componente orizzontale della velocità è l’elemento più importante per la formazione di valanghe, mentre la componente verticale è il fattore che determina la portata e il tipo di nevicata.
3 – Lo scambio di calore può rendere la neve in superficie più fragile e più esposta al rischio di rotture. Il calore può essere trasmesso verso il manto nevoso, o abbandonarlo, attraverso uno scambio turbolento. Se l’aria è più calda della neve si avrà un aumento di temperatura della neve.
Il calore può anche essere trasmesso verso la superficie della neve tramite la condensazione che deriva dalla diffusione del vapore acqueo.
FORMAZIONE DELLE VALANGHE
La neve è in costante movimento
interno e trasformazione a causa dell’elevata porosità; la gravità e i
cambiamenti di temperatura provocano un aumento della compattezza e della
densità del manto.
Vi sono due tipi principali di valanghe:
Le prime si innescano sulla superficie del manto nevoso, o comunque negli strati più alti; esse si staccano da un singolo punto e durante la caduta si allargano trascinando con loro sempre più neve.
Ma la vera forza delle valanghe a poudreose è lo spostamento d'aria provocato dall'onda d'urto.
In alcuni casi, quando la valanga si verifica in prossimità di centri abitati, lo spostamento d'aria può abbattere muri, pali della luce ed anche complete abitazioni come si è verificato in Austria nel 2000.
La valanga a lastroni viene, a volte, provocata dal taglio della coltre causato dal passaggio di sciatori su pendii in un momento di instabilità della massa nevosa. Per affrontare percorsi in fuori pista è necessario conoscere bene la montagna e la dinamica delle valanghe poiché le condizioni di pericolo variano di ora in ora in funzione della temperatura, del vento e dell'inclinazione della radiazione solare.
PROTEZIONI CONTRO LE VALANGHE
Il bosco di protezione
Il bosco di protezione può ridurre il pericolo di caduta di valanghe!
Un bosco costituito da alberi di altezze e di età diverse, raccolti in gruppi, rappresenta la miglior protezione contro le valanghe. Le chiome degli alberi trattengono una parte della neve che cade, a blocchi, al suolo. Il manto nevoso nella regione boschiva è dunque molto disuguale e il pericolo di distacco di una valanga debole. In un manto nevoso di forma regolare, possono formarsi tensioni che impediscono lo slittamento del manto nevoso. Se queste tensioni vengono rotte, per esempio da uno sciatore, è possibile la formazione di una valanga. Il bosco di protezione ideale è formato di alberi di altezza e età variabile. Il forestale abbatte di proposito alberi isolati con l’intenzione di realizzare gruppi di alberi di una certa densità. Uno stato uniforme ritarderà lo sviluppo di giovani alberi. Per tale ragione il pericolo può aumentare se i boschi non vengono rinnovati e deperiscono.
Le opere di protezione
Oltre il limite delle foreste opere di protezione impediscono il distacco di valanghe o, contengono i movimenti della massa di neve entro limiti ragionevoli.
Manufatti come muri, pannelli, frangivento a croce sono ostacoli all’azione del vento e mezzi efficaci di lotta contro la formazione di cumuli di neve o l’accumulo di una quantità esagerata di neve. Con queste opere si evita che la neve si accumuli in maniera importante alla sommità del canalone, impedendo così il distacco della valanga.